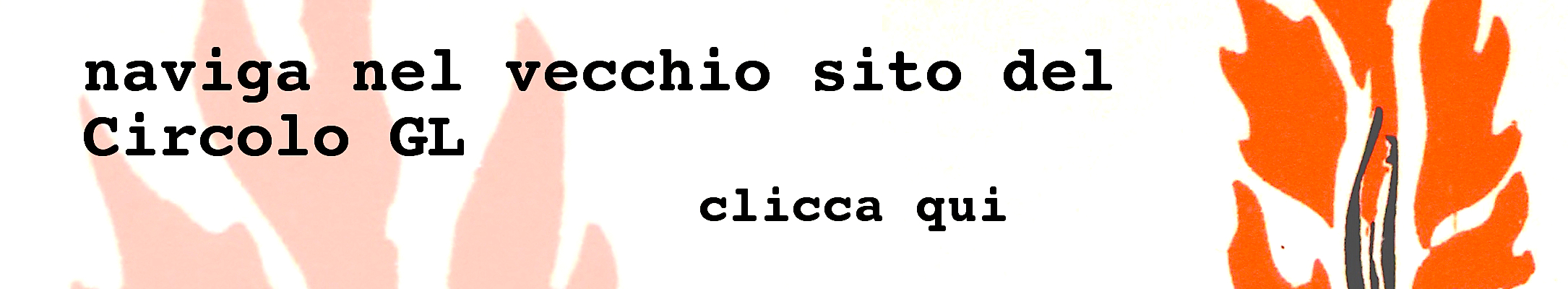Enrico Mancini: storie familiari intorno alla Giustizia e alla Libertà
Pubblicato nel numero 2/2021 de “Quaderni del Circolo Rosselli” (anno XLI, fascicolo 142 pag. 165)
Alla memoria di Riccardo Mancini
Articolo a cura di Iacopo Smeriglio -[ Studente di Giurisprudenza presso Roma Tre ]
Enrico Mancini nacque il 13 ottobre 1896 a Ronciglione, un paese della provincia di Viterbo, che all’epoca contava circa seimila anime arroccate nei monti della Tuscia. Insieme ai genitori Luisa Pizzuti e Francesco Mancini, presto si trasferì a Roma. Negli anni della giovinezza imparò a maneggiare il legno, apprendendo ed iniziando a praticare il mestiere di ebanista presso alcune botteghe. Fu, questa, una delle attività che, anche negli anni più difficili, gli permise di mantenere dignitosamente la famiglia e di difenderne l’indipendenza economica.
Con l’arrivo del primo conflitto mondiale, Mancini, che nel 1915 aveva diciannove anni, si arruolò nell’esercito regio. In battaglia dimostrò coraggio e così, al rientro a Roma, fu fregiato nel 1921 della Medaglia al Valor Militare dal Ministero della Guerra. Gli anni che seguirono furono intensi. L’attività lavorativa frenetica lo portò, presto, ad aprire una sua propria bottega ed avviare il commercio dei mobili e delle altre produzioni. Fu quello il periodo in cui, nel frattempo, avvenne l’incontro con Argia Morgia: una giovane insegnante di scuola elementare, che abitava nella zona di Via Po’. Enrico Mancini si innamorò e insieme, da quel momento, furono una famiglia, arrivò il matrimonio e, quindi, i figli. Abitarono prima nella casa familiare di lei, per poi trasferirsi dal 1922 in Via di Sant’Elena, vicino Largo Argentina, e successivamente a Testaccio, in Via Mastro Giorgio.
In una lettera degli anni ’30, che Enrico scrisse alla moglie probabilmente per rimediare ad un allontanamento temporaneo, traspare l’amore sincero che non lo abbandonò mai:
“Mia cara Argia, mi giunge in questo momento anche la tua del 31. Essa mi è
d’argomento e mi dà lo spunto per dirti, o meglio, ripeterti, quanto di persona
spesso non sono capace a spiegarti.
Ed è proprio su questo foglio, che a distanza di qualche anno, voglio riparlarti
intimamente di noi; e ripeterti brevemente, forse con altre parole, sempre sincere,
il mio pensiero sul nostro amore e sulla nostra vita. […] Ma vedi: gli anni,
pur lasciando intatta nel mio amore questa fiamma, l’hanno enormemente accresciuta
di quello stesso amore e della responsabilità della famiglia.
[…] Io chiedo a te Argia, di tornare ad essere la mia donna, il mio amore, con
tutto il risveglio del tuo grande sentimento; e chiedo anche la tua forte, piena e
intelligente collaborazione, della quale avrò tanto bisogno per sperare ancora di
poter vincere nella vita”.
Gli anni ’20 del Novecento, come sappiamo, portarono il fascismo e la società italiana cambiò.
Le biografie personali, intime, si incrociano inevitabilmente con l’evolversi circostante della Storia e così accadde anche ad Enrico Mancini.
Enrico Mancini, infatti, non nascose mai il suo fiero rifiuto del fascismo. In città lo sapevano tutti, e con il passare del tempo ed il rafforzarsi del regime, questa convinzione cominciò ad avere un peso e delle conseguenze. Negli anni, le sue botteghe vennero ripetutamente danneggiate e date alle fiamme. Insieme alla sua famiglia fu costretto ad andare a vivere alla Garbatella, dentro gli alberghi suburbani, palazzi popolari di nuova costruzione – furono edificati tra il 1927 e il 1929 – in cui il regime stava concentrando antifascisti e persone da tenere sotto controllo. Nonostante le pressioni e le violenze, che si abbatterono su di lui e sulle sue proprietà, Enrico Mancini non aderì mai al Partito Nazionale Fascista.
Nei venti anni tra le due guerre Enrico e Argia misero al mondo quattro figli maschi e due figlie femmine: Alberto, Bruno, Adolfo, Mirella, Elettra e Riccardo. Una famiglia larga e tante bocche da sfamare, che però non impedirono di continuare ad aiutare compagni e disoccupati in difficoltà.
In un testo il figlio Adolfo, raccontando quella fase della vita del padre, scrive:
“Mi ricordo ancora quando aveva una piccola trattoria, tutti gli amici antifascisti
e disoccupati (perché a quei tempi se non eri iscritto al fascio non trovavi
lavoro) venivano a mangiare gratis, perché non potevano pagare. Allora nostra
madre faceva un pacchetto di viveri per ognuno di loro. Mio padre aiutava tutti
nel suo ambito di conoscenze, mia madre aiutava la gente del quartiere e del
palazzo dove noi abitavamo”.
Enrico Mancini negli anni ’30 era un nemico del regime, ma nonostante le difficoltà aprì e gestì diverse attività commerciali nel centro di Roma. Nel periodo che va dal 1930 al 1933 tenne aperta una segheria nelle vicinanze di Via Labicana: i mobili che costruiva venivano spediti perfino in Africa. Molti clienti, però, sapendo della sua opposizione al fascismo, non pagavano, consapevoli che Mancini non potesse reclamare, e così fu costretto a chiudere per fallimento. Tra il 1934 e il 1936 gestì, presso Via di Ripetta, la Trattoria La Reginetta e poi, tra il 1938 e il 1944 diede vita insieme ad altri soci alla Società SPAI, per il commercio di prodotti agricoli industriali e la vendita dell’acqua minerale. L’ufficio della società si trovava in Via Mario de’ Fiori, a pochi passi da Via del Corso. Arrivò a possedere, cosa rara per quell’epoca, anche una macchina, che utilizzava per viaggiare per il commercio e che fu presto sequestrata e poi distrutta dai militi fascisti.
La conoscenza dell’attività commerciale e artigiana di Enrico Mancini ci permette di inquadrare il contesto in cui egli agiva e costruiva legami e relazioni, che diventarono eversive e non poterono che intensificarsi con l’arrivo della Seconda Guerra Mondiale e, poi, della Guerra di Liberazione a Roma. Una vasta rete di distribuzione, di clienti, i magazzini e i locali nel centro della città e il supporto della famiglia, gli permisero di muoversi tra i quartieri e dentro e fuori la città, di prendere parte e ospitare incontri e riunioni. Già dal 1943, con la stampa del primo numero de “L’Italia Libera”, aderì alla formazione del Partito d’Azione.
“La ricomposizione di una rete organica del PdA romano si determinò grazie
alla convergenza delle relazioni tra esponenti storici dell’antifascismo laico ed i
nuovi gruppi giovanili, portando a sintesi il rapporto tra ambienti sociali popolari
e della media borghesia intellettuale e definendo così una perfetta simmetria
identitaria tra il profilo interclassista delle formazioni GL e la conformazione
politico-sociale della capitale[1]”.
Leone Ginzburg, che fino all’arresto e poi alla morte in carcere, fu esponente di massimo rilievo dell’organizzazione a Roma, in un numero del giornale del PdA del 15 settembre 1943, scriveva parole dure indirizzate ai Savoia e alla classe politica connivente con il regime. Poneva acutamente e con enorme lungimiranza, il tema del necessario ricongiungimento della comunità europea, a testimonianza dello spessore dell’elaborazione politica di cui in quegli anni si fecero portatori nella società italiana:
“E forse qualcuno di loro avrà capito che tutto il passato ha da essere snidato e
distrutto nelle nostre istituzioni politiche e sociali, e non soltanto l’aggettivo
“fascista” sulle targhe e i frontoni dei palazzi, per far sì che l’Italia si ricongiunga
di nuovo alla civiltà europea [2]”.
È con l’armistizio, però, che l’attività clandestina di Enrico Mancini assume maggiore rilievo. L’8 settembre 1943 a Roma fu uno spartiacque decisivo per le biografie personali di migliaia di antifascisti di tutte le formazioni.
“I partiti antifascisti nel quadro di questi mutamenti in itinere e dopo la presa
d’atto di come l’idea originaria dello scontro risolutivo con i tedeschi fosse venuta
meno col farsi concreto della storia, avviarono nel Paese, e in condizioni particolari
a Roma, questo complesso processo di trasformazione pur mantenendo
al loro interno forme organizzative visibilmente distinte riguardo la lotta clandestina
nella capitale […]. L’eredità storico-politica dell’azionismo, che vedeva
la guerra di popolo come elemento insieme spontaneo ed educativo delle masse,
portò il PdA a Roma a dare una forma organizzativa organica tra sfera politica
e ambito militare che invece i comunisti mantennero rigorosamente distinte
distaccando completamente i GAP centrali dal resto dell’organizzazione armata
di massa[3]”.
Enrico Mancini abitava alla Garbatella, al Lotto 43 in via Percoto. Da lì sono poche centinaia di metri per arrivare a Porta San Paolo, dove il 10 settembre 1943 si verificò lo scontro con le truppe naziste che dopo l’armistizio stavano occupando la città. Le migliori previsioni delle formazioni antifasciste romane contavano sulle undici divisioni del regio esercito di stanza a Roma, contro le sole due agli ordini di Kappler. Il Re e i generali, invece, con tutto lo stato maggiore, fuggirono verso Bari nelle prime ore dall’ufficializzazione dell’armistizio, lasciando le truppe allo sbaraglio. Così a Porta San Paolo, nella battaglia che segnò l’inizio della Resistenza italiana all’occupazione nazista, a combattere ci furono centinaia di civili antifascisti, organizzati e non, a sostegno dei militari rimasti. È giusto pensare, vista la precedente esperienza di guerra, la vicinanza e l’impegno antifascista di Enrico Mancini, che in quelle lunghe ore di fuoco anche lui fosse stato mobilitato dal Partito d’Azione.
L’inizio dell’occupazione segnò, in ogni caso, una svolta nella vita della famiglia intera. Le attività clandestine si intensificarono e nei mesi successivi all’8 settembre ospitarono e nascosero, in casa e nei vari magazzini, militari, ufficiali e compagni. Non di rado Enrico assegnava consegne e commissioni ai figli che, come hanno poi raccontato Adolfo ed Elettra,
erano incaricati di portare pacchi di indumenti e soldi in giro per la città occupata. Capitava che fossero loro, che all’epoca avevano quindici anni circa, ad attaccare volantini e manifesti de L’Italia Libera sui muri del quartiere o sui lampioni. Le attività di rete e di informazione non sfuggirono alla polizia segreta fascista, che fece irruzione nell’ufficio di Mancini già sul finire del 1943. Nei primi mesi del 1944 non interruppe l’azione clandestina e durante il periodo che immediatamente precedette l’arresto, Enrico Mancini svolse varie e ripetute riunioni nella zona di Piazza Vittorio.
Questi sono racconti dei figli, che in prima persona vissero quei giorni accompagnando il padre e contribuendo in piccolo alla sua azione clandestina e di resistenza. Sono preziosi, ma limitati, strumenti per tratteggiare i contorni di un’attività clandestina instancabile, fatta di relazioni, incontri e riunioni: intelligence e coordinamento delle informazioni, un ruolo di raccordo fondamentale nella struttura della azione e della direzione politica della Resistenza del Partito d’Azione in città. Tra gli uomini con cui nel tempo entrò in contatto, stando a quanto riportò suo figlio Adolfo, ci furono anche dirigenti di massima importanza quali, tra gli altri, Emilio Lussu.
Il 7 marzo 1944 sedici militi della Polizia dell’Africa Italiana fecero irruzione nell’ufficio di via Mario de’ Fiori. Enrico Mancini fu arrestato insieme ad altri tre uomini: il conte Dottri, il generale Santoro e l’ex Governatore Motta. Fu trasferito alla Pensione Oltremare e torturato con violenza dalla Banda di Pietro Koch[1]. L’obiettivo evidente delle sevizie era ottenere nomi per far cadere l’intera rete clandestina di cui lui era a conoscenza. Nei tredici giorni, fino al 20 marzo, che trascorse nelle mani della Banda Koch le torture furono ripetute, ma inutili. La famiglia fu, inoltre, coinvolta in una trattativa illusoria finalizzata ad un possibile rilascio, che non venne mai realizzato e che gli costò l’intera fortuna rimanente. In quel momento, reclusi con lui nella Pensione Oltremare, in Via Principe Amedeo 2, c’erano tanti dirigenti di spicco del Partito d’Azione come Pilo Albertelli. La dimensione orizzontale e fluida della dirigenza politica e militare, non separate a compartimentazione stagna, aveva infatti determinato una maggiore semplicità di infiltrazione per la polizia segreta fascista, favorendo l’arresto di parte dei vertici della resistenza azionista.
“Dal 10 al 16 marzo si preparò dal gruppo Eluisi (settore Ponte) l’assalto alla
Pensione Oltremare, in via Principe Amedeo 2, per salvare dagli sgherri di Caruso
e Perrone alcuni dei nostri martiri […]. Improvvisamente i nostri compagni
il 20 marzo furono trasferiti dalla tetra pensione della tortura a Regina Coeli,
quattro giorni prima dell’estremo supplizio[2]”.
A Regina Coeli, Enrico Mancini arrivò con una perforazione all’orecchio e con le costole rotte. Nell’ultima lettera che scrisse, indirizzata al figlio Bruno ed oggi conservata al Museo di Via Tasso, emerge l’apprensione per la famiglia e l’amore profondo che lo legavano ai suoi cari, nella piena consapevolezza della condizione dura in cui tutti insieme si trovavano.
“E tu, mi raccomando mio caro, tu che sei rimasto l’ultimo in famiglia, prova a
rimanere fuori di casa il meno possibile […].”
Il 23 marzo 1944 in Via Rasella, a pochi passi da Piazza Barberini, i GAP portarono a termine la più grande azione di guerriglia urbana realizzata in una Capitale d’Europa contro un intero battaglione nazista: furono trentadue i tedeschi uccisi in pieno giorno. Un’azione che arrivava in un contesto di profonda instabilità a Roma, in cui l’esercito nazista era costantemente bersagliato da attacchi di guerriglia che ne fiaccavano morale ed energie.
[1]Archivio ANFIM, www.mausoleofosseardatine.it , Enrico Mancini, Scheda n°208.
[2]Attività partigiana. Relazione IV Zona Centro, Circolo Giustizia e Libertà, Roma
“Il Comando germanico ha, perciò, ordinato che per ogni tedesco ucciso, dieci
criminali comunisti badogliani siano fucilati. Quest’ordine è già stato eseguito[1]”.
L’affronto era senza precedenti: Roma, che nelle previsioni nazisti sarebbe dovuta servire come linea di riserva e ristoro per i soldati impegnati al fronte di Cassino, diventava mese dopo mese un luogo in cui i soldati tedeschi non solo non erano benvenuti, ma non erano più al sicuro.
“Alle 9,45 il Caruso, accompagnato dal Ten. Koch, che in quel tempo svolgeva
funzioni di polizia non ben definite, si presentava dal Kappler. Questi spiegava
ai due come, per completare una lista di persone da fucilare in conseguenza
all’attentato di Via Rasella, aveva bisogno di cinquanta persone arrestate a disposizione
della polizia italiana e spiegava i criteri in base ai quali egli aveva già
compilato una lista di 270 persone.
A conclusione di questo colloquio si stabiliva che il Questore Caruso avrebbe
fatto pervenire al Kappler per le ore 13 un elenco di cinquanta persone[2]”.
Nella lista stilata da Pietro Koch figurava, tra i primi, il nome di Enrico Mancini. Il 24 marzo 1944, per ore, nelle cave che si trovavano sulla Via Ardeatina, uomini di ogni età ed estrazione, cattolici ed ebrei, comunisti, monarchici, socialisti, furono trasportati su autocarri e fucilati. Terminata l’esecuzione, per nascondere le prove e occultare la memoria di quanto avevano compiuto, i nazisti fecero detonare l’intera area. Furono 335 gli uomini che in quel giorno trovarono la morte nella brutalità nazifascista. I corpi irriconoscibili e martoriati impiegarono anni per essere riconosciuti.
La morte di Enrico Mancini non fu mai notificata ufficialmente alla famiglia dalle autorità nazifasciste.
Fu solo grazie agli indumenti rinvenuti, a un pettine e agli occhiali che era solito portare, che ne fu possibile, tempo dopo, il riconoscimento. La famiglia perse le attività commerciali, le proprietà e, con queste, l’opportunità di una vita diversa.
Furono più di 50 i caduti del Partito d’Azione quel giorno.
La memoria di Enrico Mancini rimane oggi viva grazie all’impegno costante dimostrato dai figli nel tramandare questa importante storia familiare alle generazioni che sono venute. Riccardo Mancini, più piccolo tra i figli, ha dedicato l’intera vita al passaggio del testimone della sua storia, raccontando di Enrico e delle Fosse Ardeatine nelle scuole e, ogni anno, al Mausoleo.
I compagni del Partito d’Azione apposero una targa, nel 1947, al Lotto 43 in Via Percoto alla Garbatella, che ne ricorda ancora oggi, con lettere impresse nel marmo, il sacrificio compiuto in nome degli ideali di Giustizia e di Libertà, che neanche le torture e il carcere riuscirono a piegare.
Nel 2020 il ritratto di Enrico Mancini è stato realizzato dall’artista Francesco Pogliaghi sul muro di un palazzo in Piazza Bartolomeo Romano, alla Garbatella. Un volto che racconta la storia di un uomo e che ha l’ambizione di rappresentarne molti: tutti coloro che caddero lungo la strada della democrazia, della libertà e della giustizia sociale, contro l’occupazione nazifascista nella costruzione del mondo nuovo.
______________________________________________________
[1]Agenzia Stefani, il Messaggero, Roma (25 marzo 1944).
[2]Sentenza n. 631, Tribunale Militare Territoriale di Roma, 20.07.1948.
Bibliografia
G. De Luna, Storia del Partito d’Azione 1942-1947, Editori Riuniti, Roma, 1977.
D. Conti, Guerriglia partigiana a Roma, Odradek, Roma, 2016.
A. D’Orsi, L’intellettuale antifascista, Neri Pozza Editore, Vicenza, 2019.
C. Rosselli, Socialismo liberale, Einaudi Editore, Torino, 2009.
Attività partigiana. Relazione IV Zona Centro, Circolo Giustizia e Libertà, Roma.
Archivio ANFIM, www.mausoleofosseardeatine.it.
I partigiani d’Italia, Lo schedario delle commissioni per il riconoscimento degli uomini e
delle donne della Resistenza, www.partigianiditalia.beniculturali.it .
[ pubblicato da Administrator ]